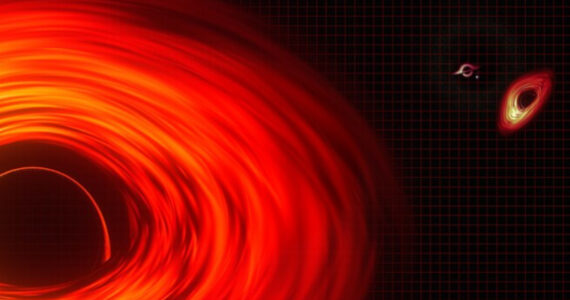Il crowdfunding è un metodo di finanziamento collettivo che mette insieme i contributi volontari di persone comuni per dar vita a progetti che da soli non si possono sostenere. E ci riguarda molto più da vicino di quanto crediamo.
IN BREVE
Una giacca da viaggio dotata di optional multifunzione per le scomode traversate in aereo, con cuscini e tasche porta-device incluse. Una manifestazione notturna su scala nazionale che ha portato tutta l’Olanda a marciare per i diritti dei rifugiati. Un gioco di carte a tema gatti esplosivi, raggi laser e capre. Può questo improbabile trio avere qualcosa in comune? La risposta è nel modo in cui tutti e tre hanno raccolto soldi per dare il via ai progetti – e parliamo di moltissimi soldi, tutti dell’ordine dei milioni di euro. Dietro a questi decolli infatti non ci sono investitori miliardari o colossi delle multinazionali, ma persone qualsiasi riunite per scelta intorno alla stessa motivazione. Questi progetti sono figli del crowdfunding, un metodo di finanziamento che ha il suo habitat su internet e sta spopolando negli ultimi anni. E se vi dovesse interessare, sia la Baubax Jacket che il gioco Exploding Kittens sono ad oggi (inspiegabilmente) reali e recuperabili sul web.
Partiamo da qualche definizione. Detto in breve, il crowdfunding è una pratica di fundraising su larga scala, vale a dire un mezzo per raccogliere fondi che non si rivolge a pochi investitori, ma a un numero indefinito di persone che partecipano in maniera volontaria. Detto meno in breve, è un metodo legato al concetto di microfinanza, che si basa sul contributo libero e in proporzione volontaria delle persone a supporto di progetti di vario genere – eventi, imprese, oggetti, qualsiasi cosa. L’idea di fondo del crowdfunding è che chi ha un’idea che immagina potrebbe avere successo, invece di proporla solo a un investitore per avere un finanziamento, la rende pubblica in modo che tutti gli interessati possano contribuire al progetto. La misura in cui contribuire è di solito lasciata a discrezione di ognuno, e vi può anche corrispondere una sorta di ricompensa da parte dell’ideatore. È proprio il tipo di ricompensa a classificare le pratiche di crowdfunding in quattro categorie, come vedremo più avanti.

Facciamo un esempio. Se masticate di tecnologia il nome Pebble Technology Corporation potrebbe suonarvi familiare. È una ormai defunta casa di produzione di dispositivi mobili, resa famosa dalla creazione nel 2012 del Pebble Smartwatch, il primo orologio intelligente ideato per un mercato di massa dalla mente del venticinquenne canadese Eric Migicovsky. Non si trattava in alcun modo del primo smartwatch, che anzi erano in circolazione dai primi anni Duemila nelle loro forme primitive, ma fu il primo a rivolgersi a un pubblico più ampio che non la solita nicchia di appassionati, e lo fece unendo un costo contenuto a funzionalità pensate apposta per completare quelle di uno smartphone. Un trionfo. Il successo fu tale da spingere altri produttori a muovere i primi passi su questo sentiero ancora poco battuto nel mercato dei device, portando a una competizione che vedrà in campo, fra gli altri, il Samsung Galaxy Gear (2013) e l’Apple Watch (2015). Ma perché ci interessa?
La cosa più notevole riguardo al Pebble non è nelle sue caratteristiche tecniche, ma nella storia della sua genesi. Il Pebble Smartwatch è nato solo grazie a finanziamenti su Kickstarter, la più nota piattaforma di crowdfunding nel web datata 2009, raccogliendo un totale di oltre 10 milioni di dollari da 68mila donatori che hanno creduto nel progetto. Le regole di Kickstarter sono semplici: chiunque può mettere in vetrina la sua idea e per il mese successivo tutti quelli che vi vedono un potenziale possono decidere di mettere una qualsiasi somma di denaro. Se alla fine del mese il progetto ha raggiunto almeno la base fissata per cominciare a produrre (che nel caso di Pebble si trattava di 100mila dollari) la campagna ha successo, i soldi vengono effettivamente presi dai backer, i finanziatori, e gli ideatori si mettono all’opera per realizzare l’oggetto tanto atteso. Spesso è garantito a ciascun backer un modello del prodotto come ringraziamento, come se lo avessero normalmente preordinato. Sbarcato su Kickstarter l’11 aprile 2012, Pebble aveva già raccolto i 100mila dollari necessari dopo appena due ore. 26 ore più tardi superava il milione.

E in tutto questo, Pebble Smartwatch non è nemmeno la campagna più fruttuosa negli archivi di Kickstarter – il primato appartiene ora al successore Pebble Time (2015) con più di 20 milioni di dollari raccolti, dopo aver superato il rivale al trono Coolest Cooler, minifrigo-frullatore multifunzione fermo ad “appena” 13 milioni. Non sono solo dimostrazioni di start-up fatte egregiamente, ma di come il web degli ultimi anni sia terreno fertile per pratiche grassroots, cioè realizzate per iniziativa e dall’impegno collettivo di persone comuni, senza interventi dall’alto dei colossi dell’economia. È un fenomeno interessante, perché il concetto di crowdfunding non si limita a progetti fantasiosi su Kickstarter (e con fantasiosi intendiamo anche cose assurde e spettacolari come tornei di lotte tra robot – sì, è successo anche quello), ma nelle sue diverse sfumature è molto più presente nelle nostre vite di quanto immaginiamo. I modelli di raccolta fondi sono generalmente distinti in base al ritorno che ne ottiene il backer:
- Equity-based: i finanziatori hanno un guadagno in forma di partecipazioni azionarie. Lo si potrebbe credere un modo alternativo per chiamare la borsa azionaria e non si sarebbe troppo lontani dalla realtà. I backer in questo caso sono anche shareholder, cioè soci dell’azienda, da cui hanno un ritorno monetario.
- Lending-based: chi investe soldi nel progetto si aspetta che gli ritornino i soldi prestati, con eventuali interessi. Anche in questo caso la motivazione è finanziaria, e funziona in modo simile alle obbligazioni in borsa ma in maniera P2P, “da pari a pari”: il donatore non compra niente, né azioni né prodotti, ma è a tutti gli effetti un creditore dell’impresa, che una volta avviata gli darà indietro l’investimento.
- Reward-based: per i backer non è previsto nessun ritorno economico, ma una ricompensa che può essere materiale, come il preordino del prodotto, oppure intangibile, come un ringraziamento sul sito. È il modello più interessante, nonché quello a cui si pensa immediatamente parlando di crowdfunding, perché trova la sua massima espressione nelle piattaforme online. Siti come Kickstarter, Patreon o Indiegogo permettono di finanziare creatori di prodotti e contenuti ottenendo in cambio riconoscimenti che vanno da edizioni speciali dell’oggetto all’accesso a extra esclusivi, fino a copie omaggio o ringraziamenti formali. È la più vasta e variegata delle categorie. Anche quando alla fine di un video su Youtube si vedono scorrere i ringraziamenti del canale, quello è un ritorno reward-based ai suoi sostenitori. Si tratta del modello di crowdfunding più diffuso in Italia.
- Donation-based: nessuna ricompensa, chi finanzia il progetto non lo fa per averne un ritorno, ma perché crede nella causa. È l’esempio della già citata marcia per i rifugiati organizzata in Olanda, ma troviamo casi di donation crowdfunding anche in Italia, come la raccolta fondi avviata da Eppela in risposta al terremoto di Amatrice. Concettualmente non ha niente di diverso da un’opera collettiva di beneficenza, ma usare internet come mezzo consente di raggiungere il maggior numero di donatori nel minor tempo possibile.
Mentre i primi due modelli prevedono una forma di ritorno economico, gli altri fanno piuttosto leva su motivi sociali, di appartenenza a una causa o una comunità, di gratitudine verso il produttore – mettiamo caso un videomaker che ha sempre pubblicato i suoi contenuti gratuitamente ma lascia agli spettatori più fedeli la possibilità di fare donazioni. È la cosiddetta gift economy, un’economia di condivisione in cui assume valore non solo il prodotto in vendita, ma lo stesso rapporto con l’ideatore, come se si instaurasse una solidarietà fra pari. Questo tipo di sentimento, lontano dalle economie strettamente commerciali, è ciò che rende possibile l’uso del crowdfunding per scopi socialmente utili o umanitari.

Spirito di comunità e senso sociale sono proprio le parole d’ordine nei progetti di civic crowdfunding, un’economia con finalità civiche e sociali che si affida al senso di cittadinanza delle persone per dar vita a progetti, servizi e infrastrutture di cui lo Stato non può farsi carico da solo. Il primo caso di civic crowdfunding che la storia moderna ricordi risale a molto prima di internet, a quando nel 1884 una campagna di sottoscrizione pubblica avviata da Joseph Pulitzer per dare un piedistallo alla Statua della Libertà raccolse 100mila dollari da oltre 120mila donatori americani in appena 5 mesi. Ad oggi troviamo progetti di crowdfunding civico anche in Italia, come l’iniziativa Milano Smart City per l’accessibilità urbana nel capoluogo lombardo, oppure il progetto Meridionare contro i disagi sociali del Sud. I cittadini sono chiamati a fare la loro parte in quelle realtà che li riguardano più da vicino.
La varietà di situazioni in cui vediamo applicare le diverse forme di crowdfunding mette in luce un bisogno diffuso, soprattutto nel pubblico di internet: più che dal prodotto in sé, i backer sono spinti a contribuire dall’idea di partecipare alla costruzione di qualcosa, che l’oggetto finito e distribuito esista anche grazie alla loro parte. È un bisogno di appartenenza a qualcosa di più grande e condiviso. Lo stesso motivo che porta sempre nuovi fundraiser a esporre i loro progetti nelle vetrine virtuali di Kickstarter e i piccoli creatori a rischiare con iniziative grassroots invece che conformarsi ai colossi dell’economia: il sentirsi parte di una comunità mondiale e indipendente della rete.
Fonte
- Crowdfuture – The future of crowdfunding
Crowdfuture - Transmedia Design Framework
M. Ciancia - Le Piattaforme di crowdfunding
ItalianCrowdfunding - Vancouver-born entrepreneur’s Pebble smartphone breaks Kickstarter record
Vancouver Sun - Olanda, crowdfunding da record per la notte dei rifugiati
ItalianCrowdfunding - Da Nord a Sud: il fil rouge del Civic Crowdfunding italiano
ItalianCrowdfunding